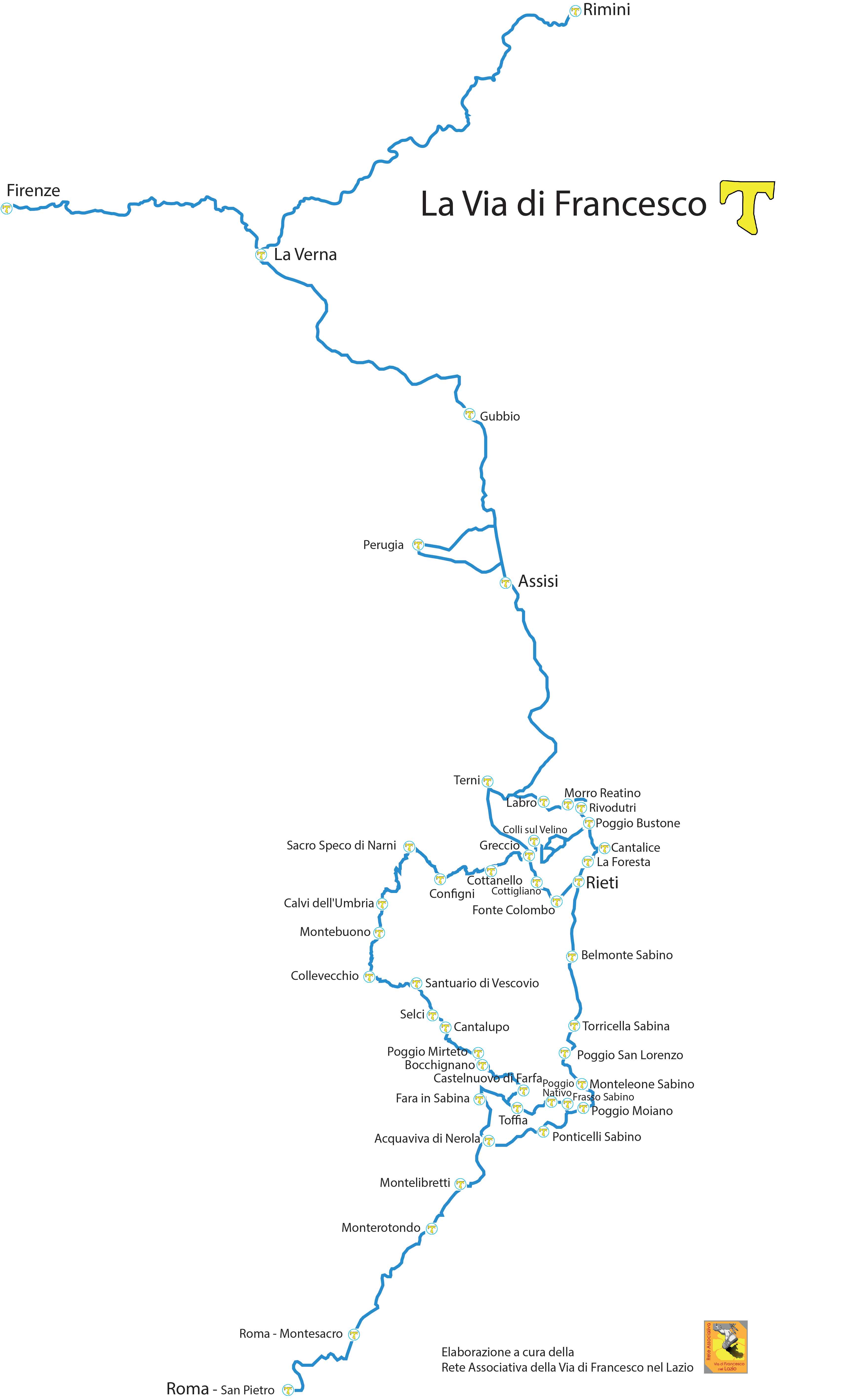Palazzo Nobile Vitelleschi
Tipologia: monumento
Sito Visitabile: internamente
Indirizzo: Via Santa Maria Maggiore 4, 02010 Labro (RI)
Orario: visite guidate tutti i giorni ore 10:00 – 11:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 -19:00
Prenotazione visite: 0746636020 - 3487038840
Geolocalizzazione: 42° 31' 33.88'' N, 12° 48' 0.57'' E
La fondazione del castello risale al IX – X secolo, periodo in cui sorsero vari incastellamenti sulle pendici sudovest del Terminillo.
Aldobrandino de’ Nobili (famiglia con probabili origini longobarde), ricevette dall’imperatore Ottone I di Sassonia l’investitura per il Borgo di Labro e per altri castelli e insediamenti nei territori di Rieti e Spoleto, oltre allo stemma recante l’aquila simbolo del Sacro Romano Impero assieme al pesce, attestante il dominio sulle acque del territorio.
Intorno alla metà del Quattrocento il castello originario, troppo ampio per poter essere difeso adeguatamente, venne abbattuto e riedificato, assieme al borgo ricostruito addossando le case le une alle altre.
Successivamente, in seguito alla scomunica della famiglia da parte di Papa Sisto IV nel 1476 per l’uccisione di un sacerdote avvenuta per mano di Giovanni de’ Nobili, l’imponente torre principale venne abbattuta e al suo posto edificata la chiesa di Santa Maria Maggiore (v.) come opera di espiazione.
Nella seconda metà del 500 Giordano de’ Nobili ricostruì la dimora fortificata lungo la cinta muraria, a un livello inferiore rispetto all’originale.
Nel 1575 la famiglia si imparentò con quella dei Vitelleschi tramite le nozze tra Gerolamo de’ Nobili e Virginia Vitelleschi.
Lo stemma con aquila e pesce dei Nobili venne unificato con quello recante i vitelli e i gigli dei Vitelleschi in un unico stemma, visibile oggi nella sala d’armi.
Il palazzo attuale in pietra grigia sorge addossato alle mura lungo la Via di Santa Maria Maggiore, e dalle sue torri si può godere del panorama delle piana reatina oltreché della vista sul Lago di Piediluco in territorio umbro.
L’aspetto odierno risente della risistemazione operata tra ‘700 e ‘800, con giardini pensili attraversati da una doppia scala e loggette, balconi, merlature sulle mura esterne.
Nelle sale interne si conservano gli arredi d’epoca, armi, antichi ritratti della famiglia e un camino cinquecentesco in marmo.
E’ abitato a tutt’oggi dai discendenti di Giordano de’ Nobili.
Testo: Raffaello Conti
Foto: Associazione culturale ambientalista “Organizzazione Alfa”
Chiesa Santa Maria Maggiore
Tipologia: sito religioso
Sito visitabile: internamente
Indirizzo:Via di Santa Maria Maggiore, 02010 Labro (RI)
Orario:aperto per le funzioni religiose
Per info: Parrocchia 0746636237 Don Luciano Candotti
Geolocalizzazione: 42° 31' 34.03'' N, 12° 48' 2.79'' E
Sita nella parte alta del paese, fu costruita sul luogo in cui era originariamente la sala d’armi della rocca dei Nobili di Labro.
La trasformazione della antica torre del castello in chiesa fu il pegno per la revoca della scomunica inflitta da Papa Sisto IV alla famiglia per l’uccisione di un sacerdote da parte del Signore Giovanni alla fine del ‘400.
La chiesa è in pietra con muratura a vista e presenta un portale cinquecentesco con colonne aggettanti che sostengono la trabeazione. Eretta in Collegiata nel 1508, fu sottoposta con l’occasione a interventi di ampliamento e ridecorazione.
L’interno oggi risulta arricchito da decorazioni barocche. Nella prima cappella a sinistra sono presenti manufatti ed opere rinascimentali, tra cui una transenna lignea del ‘500 con rosoncini e trifogli, un fonte battesimale quattrocentesco nel cavo della cui vasca sono scolpiti tre pesci, e l’affresco di una Annunciazione attribuito a Bartolomeo Torresani, pittore veronese che operò nel Reatino fino al 1567.
Connessa alla Chiesa, tramite una scala a metà della navata sulla destra, è la Cappella del Rosario, antecedente alla costruzione della chiesa e ricavata in un ambiente del piano superiore del castello.
Preceduta da un portale, realizzato nel 1494, recante il monogramma raggiato di Cristo e figure di rettili e scorpioni sugli stipiti, si presenta come una piccola aula rettangolare con pavimento in pietra e volte a botte.
Sopra l’altare e le pareti dell’abside sono presenti affreschi dei secoli XVI e XVII, opera di pittori locali.
L’altare, dedicato a Santa Caterina è inserito in un’edicola poggiante su una colonna romanica con fiori sul capitello assieme a una graziosa testina d’angelo.
Testo: Raffaello Conti
Foto: Associazione culturale ambientalista “Organizzazione Alfa”
Torricella in Sabina

Un centinaio di metri oltre il 68° Km della Vecchia Via Salaria, laddove questa dopo una tortuosa salita di circa sette chilometri fra estesi uliveti e folti boschi percorre un breve tratto pianeggiante si diparte la comoda strada che, tra vecchie case di campagna e moderne villette, conduce, in meno di mezzo chilometro, a Torricella Sabina, in provincia di Rieti.
Situato nella zona montuosa della regione a 615 metridi altitudine, il paese è formato da un'unica strada in leggero pendio, fiancheggiata da due file ininterrotte di case, che termina a ridosso dell'antico palazzo Cesarini al di là del quale sorge un aggregato compatto e raccolto di basse casette dalle palesi caratteristiche medievali denominato Pescheria.
Torricella è un paese prevalentemente agricolo: l'olio è il più noto e rinomato dei suoi prodotti. In altri tempi dovettero essere famosi anche i latticini dal momento che il Ferri scriveva: “vi si fanno per cagione del suo clima e degli erbosi pascoli, squisite caciotte e formaggi sodi che si sgranano e sono saporosi, dì simigliante al rinomato stracchino di Gorgonzola”.
Ancor oggi, del resto, nelle campagne circostanti si può trovare dell'ottimo pecorino.
I "torricellani" sono semplici, schietti, laboriosi, ospitali: qualità innate nelle genti della Sabina.
Non è certo se a dare il nome al paese sia stata una "piccola torre eretta dai primi feudatari oppure se la denominazione provenga da Turris Celiae, come si legge sul sigillo parrocchiale, per l'esistenza nel luogo di una antica torre in cui, secondo una vecchia leggenda, una tale contessa Celia fu rinchiusa e lasciata morire d'inedia.
Diciamo subito che di Torricella, sorta probabilmente prima del secolo X, si hanno scarse notizie.
La più antica menzione la troviamo nel Regesto Farfense dove si dice che nel mese di maggio del 1019 Tedmario, figlio di Gisone, donò all'abbazia di Farfa alcuni beni fra I quali una parte “de ipso castello quod dicitur Turricella”.
Altre citazioni, reca ancora il Regesto: in un'elencazione degli “acquisti e dei contratti principali” fatti dall'abate farfense Berardo I nel 1047 figura ancora il “castello di Turricella”; nel novembre del 1059 Giovanni e Pietro, figli di Tenza col consenso del loro tutore Gùido di Nastasia vendono a Dono, diacono di Farfa, per cinque soldi, una loro terra situata “nel luogo detto Turricella”; nell'aprile del 1065 e nel marzo del 1066 Rainiero e Grescenzio, figli di Azolino ed altri vendono all'anzidetto Dono alcuni beni situati in territorio sabinense “nel luogo detto Turricella"; nell'ottobre del 1079 è registrata una donazione fatta da Giovanni prete al monastero di Farfa.
Se ne parla ancora in una carta manoscritta da Giovanni notaio, datata giugno 1086, in cui si legge che Tassone, figlio del fu Donadeo dona al cenobio di Farfa, mentre ne era abate Berardo, ciò che possedeva nel territorio reatino, e cioè due porzioni del castello di Torricella.
Dopo di che, non si trovano notizie sino alla fine del Trecento.
Si riparla di Torricella in un documento datato 13 aprile 1388, esistente nell’archivio Sforza Cesarini, dal quale si apprende che all’epoca ne erano proprietari i Brancaleoni, nobili originari di Ferentino i quali probabilmente l’avevano ricevuto in feudo molto tempo prima, unitamente ai castelli sabini di Frasso, Ginestra e Stipes.
Torricella passò poi ad un’altra nobile famiglia, quella dei Cesarini, quando nel 1444 i fratelli Francesco e Paolo Brancaleoni donarono, insieme ad altri beni che possedevano in Sabina, una parte del castello alla sorella Simodea, detta anche Semidea, andata sposa nel 1441 ad Orso Cesarini.
Fu eretto allora, a fianco della primitiva torre, il palazzo ancor oggi esistente.
Vi sono alcune pergamene ed istrumenti da cui risulta la donazione di una parte del castello di Torricella e di alcuni beni in Oliveto fatta nel 1466 da Francesco Brancaleoni a Gabriele Cesarini figlio di Orso e di Simodea.
Il matrimonio di Livia Cesarini, figlia del duca Giuliano e di Margherita Savelli con Federico Sforza, figlio del duca Paolo e di Olimpia Oesi, avvenuto il 27 febbraio 1673, dette origine alla famiglia Sforza Cesarini che tenne il possesso di Torricella sino alla definitiva vendita del palazzo ducale e di altri beni nel 1828.
Esiste tuttora il contratto di vendita del palazzo da parte del duca Salvatore Sforza Cesarini a favore di Giovanni Paolo Janni ed Emidio Ciccaglioni vendita motivata dal pessimo stato in cui era ridotto l’immobile.
Il malandato palazzo, compresi i pochi mobili rimasti, fu venduto "per 850 scudi, pagabili in un anno, a Roma in tanta buona moneta d'oro e d’argento esclusa qualunque sorta di carta moneta od altra inferiore moneta".
L'atto reca la data del 23 dicembre 1828 e le firme di Nicola Ratti, procuratore ed agente generale di casa Sforza Cesarini, dei due compratori, e di due testimoni, Gaetano Palma e Giovanni Giuliani.
In un altro documento si parla della vendita di due terreni, l'uno in vocabolo Largo del Termine (confinante con la strada per Roccasinibalda) e l’altro “macchioso con alberi di cerro” in vocabolo Mojola entrambi acquistati da Michele Colangeli.
I duchi rimasero ancora proprietari di un immenso bosco di querce e di cerri situato a nord del paese, già dato in enfiteusi a varie persone alcune delle quali successivamente ottennero, pagando, di disboscarlo per ridurlo a cultura.
Nacquero così i fertili terreni che si possono ammirare nella zona.
Anche della storia del Comune non si sa molto. Il più antico registro di deliberazioni salvatosi dalla dispersione cui andarono soggetti molti documenti, si inizia con un atto di ordinaria amministrazione dell’11 marzo 1630, essendo “Cancellarius di Torricella Statius Statutus”.
La perdita di documenti relativi alla storia di questo paese viene sottolineata ancora una volta in questa lettera che l’abate Ferdinando Cavanna, deputato della S. Congregazione del buon Governo, scriveva nel dicembre 1789 ai priori di Torricella: “Ha regnato da tempo immemorabile nella Terra della Torricella un notabile disordine di non avere quella comunità alcun luogo fisso per uso della pubblica segreteria e di ritenersi presso il segretario pro tempore tutti i libri e scritture appartenenti alla comunità, ed altresì una piccola casettina per custodirvi il pubblico sigillo. Da ciò ne é derivata la dispersione totale delle pubbliche scritture passate da un segretario all'altro senza inventario, senza alcuna formale consegna, che pure avrebbe moltissimo contribuito alla conservazione delle medesime”.
Verso la fine del secolo scorso furono aggregate a Torricella le sue due attuali frazioni di Ornaro ed Oliveto, graziosi e tranquilli paesini lontani dagli odierni rumori e perciò assai frequentati nel periodo estivo.
Passata allo Stato italiano a seguito dello annessioni del 1860, Torricella fu aggregata alla provincia di Perugia, poi a quella di Roma ed infine nel 1927, alla nuova provincia di Rieti.
Il paese visse un paio di giornate memorabili dal 21 al 23 ottobre 1867 quando vi sostò una colonna di circa trecento volontari garibaldini provenienti da Rieti e diretti a Roma, nel corso di quella infelice impresa denomina “campagna dell’agro romano” che si concluse con la drammatica giornata di Mentana.
Così ne riferisce con semplicità e vivezza il Barrili, uno dei volontari, ponendo in risalto le dimostrazioni di generosa ospitalità offerte dalla popolazione: “Sono ottima gente, cortesi senza fronzoli e con tanto di cuore come i loro antichissimi padri. Ricorderò sempre con gratitudine il sindaco e il segretario comunale che erano due fratelli Enrico e Domenico Pitorri... I nostri ospiti (poichè in casa loro ebbi, la più lieta accoglienza) non potevano capacitarsi di come noi si sperasse di far opera gagliarda senza l’aiuto del Governo…”.
Poi, con scrupolosa fedeltà di cronista così prosegue: "l buoni abitanti di Torricella mossi a pietà del nostro stato…. ci offrivano quattordici fucili, cinque dei quali erano stati caricati due o tre anni innanzi... Comunque fosse accettammo il presente che in quelle circostanze ci parve la man di Dio.
Dopo aver ricordato che la mattina del 23 Garibaldi transitava velocemente in carrozza per Torricella diretto a Scandriglia e quindi a Passo Corese per passare il confine lo scrittore conclude dicendo: “Salutati affettuosamente i nostri ospiti cortesi lasciammo il paese alle due pomeridiane dello stesso giorno accompagnati da un’acquarugiola fine e continua… cantando il Fratelli d’Italia al popolo di Torricella che ci saluta dai margini della strada maestra, dalle finestre dei casolari, dalle prode dei campi……”
Oltre al già ricordato palazzo Cesarini, che è un po’ l’orgoglio dei torricellani, nel paese vi sono tre interessanti chiese.
Una all’inizio del borgo é intitolata a S. Antonio: é una graziosa chiesetta seicentesca privata, i cui proprietari non risiedono nel luogo, per cui essendo pressoché in disuso si va progressivamente deteriorando. Di notevole possiede un tabernacolo ligneo di buona fattura.
C’è poi la chiesa parrocchiale dedicata a S. Giovanni Battista, situata nella parte medievele del paese, la cui costruzione risale probabilmente al XII secolo.
Sulla facciata, più volte rimaneggiata, fa spicco un artistico rosone, con archetti e colonnine a tortiglione magistralmente scolpiti, che può essere riferito agli inizi del Trecento.
L’interno è ad un’unica navata; l’abside è costituita dalla curvatura semicircolare di un preesistente torrione sulle cui pareti sono stati recentemente scoperti frammenti di dipinti medioevali con figure di Santi, uno dei quali reca la data 1251; due pregevoli tele del primo Cinquecento si trovano sui due altari laterali.
Una splendida tavola a tempera raffigurante la Madonna col Bambino, attribuita da alcuni ad un anonimo artista della regione umbro-laziale del sec. XV, da altri, più verosimilmente, alla scuola del Lippi, trovasi presso la Soprintendenza. Degna d’interesse é una bella croce in stile sbalzata in argento, pregevole lavoro di oreficeria medievale, probaoilmente abruzzese, della fine del Trecento.
La terza chiesa intitolata a Santa Maria dell Grazie, con annesso un antico convento, é situata subito fuori del paese, sulla strada per Poggio San Lorenzo. Si tratta di un interessante complesso monastico di cui si hanno scarse notizie.
Unico documento esistente é una lunga relazione sullo stato del monastero, redatta il 15 aprile 1650 dai monaci Agostiniani che vi abitavano e conservata nell'Archivio generale Agostiniano, in Roma. In essa si legge che “la sua fondazione ed erezione, consenso et autorità del S.P. assegnamenti et obblighi non si possono descrivere stante che libri passati della sua famiglia attestano esser perito 1 libro nel tempo del priore Fra Angelo da Gualdo Cattano nel 1625 e 1626 nel quale potevano costare et apparire le suddette cose”. Sulla lunetta della porta d’ingresso della chiesa è ancora leggibile questa scritta incisa su pietra: “Initiun huius devotionis fuit in die Sancti Patris Augustini an. 1405”. Anche sull'architrave si legge “Salve Regina Mater Misericordiae” e più sotto: “Ecclesia fratrum servorum Xti et servorum Sancte Marie". Da questa chiesa proviene la preziosa tempera della Madonna col Bambino di cui si detto sopra.
La minuta ed interessante descrizione di tutto il complesso che gll Agostiniani facevano nell'anzidetta relazione “La struttura della chiesa e del convento”, vi si legge, “é di tre piani. Nel 1° vi è la chiesa con cinque altari con il choro e la sagrestia d'ottime muraglie…; nel 2° vi è la cucina commoda con uno stanziolino ove si conservano li mobili et massarie di tavola e cucina. Vi è il legnaro assai grande. Refettorio et granaro commodi. Vi sono quattro stalle mediocri et il cortile con vasca e vaschetello con tutti l'istrumenti necessari, come caldara murata et altri. Vi è anche il pozzo d'acqua. Nell'ingresso del monastero vi é il suo portico con loggia. Vi é anche un cortiletto con una stalla di paro lunghezza. Nel 3° piano vi é il dormitorio con sei camere cioè tre mediocri e tre grandi… Vi é anco il suo loco comune et un'altra dispensa. Vi sono anco quattro fienili sopra 1 e quattro stalle corrispondenti alla grandezza di quelle, et anco un altro fienile sopra la stalla maggiore, alla sua grandezza corrispondente; se ne cava di pigione uno scudo l'anno".
La relazione, che di ogni ambiente fornisce anche le precise dimensioni, così prosegue: "Nel convento di presente di famiglia vi habitano doi sacerdoti, cioè il padre Giovanni di detta Torricella priore, ed il padre Marcantonio del medesimo luogo; e doi conversi, cioè Frà Nicola e Frà Giuseppe parimenti del medesimo luogo… Possiede terreni arativi e lavorativi…dove si raccogliono noci et mela et pera…; possiede pezzi d'arbori, vitatidi prati, d'oliveti et cerqueti et selve di ghiande…et possiede un horto dal quale non si cava moneta ma serve solamente per uso cibario della suddetta famiglia". Seguono le firme di Frà Giovanni Pitorri priore e di due monaci.
Non si sa fino a quando gli Agostiniani siano rimasti nel convento S. Maria delle Grazie nè chi vi abbia abitato dopo di loro. Qualcuno ritiene che ad essi siano succeduti i Francescani, ma nei ricchissimi archivi generali di questi due Ordini religiosi non esistono notizie a riguardo.
Dopo il 1870, passati al Comune, chiesa e convento rimasero per decenni abbandonati a se stessi, divenendo luogo di rifuggio per gente senza tetto, abitazione di pastori e persino ricovero di armenti. Durante la Prima Guerra Mondiale vi furono concentrati per qualche anno alcuni prigionieri austro-ungarici. In seguito al Concordato, questo complesso monastico fu restituito alla Chiesa, che vi operò alcuni lavori di riordino e di restauro. Ma poi seguirono altri decenni di abbandono e di disinteresse. Nel 1975, finalmente, la chiesa è stata a fondo restaurata per l'interessamento e la generosità dell'Ing. Enrico Filippi come ricorda una lapide posta all’interno.
Durante i lavori eseguiti in S. Maria delle Grazie sono venuti alla luce alcuni interessanti affreschi sino ad allora celati da intonachi e tinteggiature sovrapposti senza criterio nel corso dei secoli: due sulla parete di destra, una Madonna in trono col Bambino e ancora, una Madonna col Bambino e S. Atonio abate; un altro, di buona fattura sul secondo altare di sinistra raffigurante anch'esso la Vergine col Figlio e ai lati, S. Nicola da Tolentino e S. Caterina d’Alessandria.
Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Torricella subì notevoli danni: alcune vecchie case andate distrutte furono poi sollecitamente ricostruite.
Numerose nuove costruzioni sorsero all'epoca del boom edilizio e successivamente, talché il paese si è molto esteso fino a raggiungere la Via Salaria: i prati, gli orti, i campi che un tempo lo cingevano da presso, accolgono oggi graziose e Moderne villette di fiori e di verde.
Per la sua posizione facilmente raggiungibile percorrendo la Via Salaria, per la sua distanza di appena 18 chilometri da Rieti e poco più di 60 da Roma, per l'ottimo clima e per la serena quiete che vi regna, Torricella é una allettante località per un riposante soggiorno estivo, un tranquillo ed interessante paesotto da scoprire.
Sito ufficiale del Comune di Torricella in Sabina: clicca qui
Testo:Giuseppe Tanteri - Paesi del Lazio (dalla rivista Lazio Oggi 1982)
Foto: Associazione culturale ambientalista “Organizzazione Alfa”
Monterotondo

In una posizione strategica al centro di un territorio che va dalla Bassa Sabina alla valle del Tevere, si trova Monterotondo, cittadina di medie dimensioni che appartiene all’area metropolitana di Roma Capitale, da cui dista circa ventitré chilometri.
Il Comune ha una popolazione di poco superiore a quarantamila abitanti ed è un centro dinamico e in continua espansione, anche per il fatto di essere ben collegato con la linea ferroviaria alla capitale e perché offre a suoi cittadini e a quelli dei centri del circondario molti servizi importanti come scuole superiori, ospedale, distretto sanitario, associazioni di categoria.
Sono presenti anche vivaci realtà culturali, come il centro polivalente che ospita la Biblioteca Civica, il Museo Archeologico e Multimediale, l’Archivio Storico Comunale e locali per convegni; ancora, il cinema nel quale si svolge ogni anno anche una rassegna, il Festival delle Cerase e il teatro comunale Ramarini, recentemente riaperto con una propria stagione di spettacoli; infine, di rilievo sono la Scuola di Musica e la banda Eretina che vantano una tradizione decennale e per la formazione permanente l’Università Popolare Eretina.
Molto diffuso è anche l’associazionismo, che conta decine di realtà di aggregazione fra i cittadini, sulle tematiche più svariate.
Monterotondo sorge su tre colli, come è rappresentato nello stemma della città, e domina la valle del Tevere lungo il percorso di due delle più antiche vie consolari del Lazio, la via Nomentana e la via Salaria.
La cittadina si divede in due macroaree, Monterotondo Paese, sviluppato intorno al centro storico del borgo più antico, e Monterotondo Scalo, nella zona pianeggiante dove si trova la stazione ferroviaria e dove si sono sviluppate la zona industriale e insediamenti abitativi più recenti.
Nelle zone di campagna che si estendono intorno al centro abitato sono ancora praticate la coltivazione degli orti, degli olivi e delle viti, con le quali si producono vini di buona qualità.
Al loro interno si distinguono aree di grande pregio ambientale e naturalistico, come Tor Mancina, la Macchia del Barco e la Macchia di Gattaceca.
Storia
Monterotondo ha origini antiche e una storia ricca e articolata che ancora è testimoniata nella sua architettura e nei suoi monumenti.
Nei pressi del territorio su cui si trova Monterotondo sorgeva la antica città sabina di Eretum, ricordata da Dionigi da Alicarnasso e Tito Livio come teatro delle guerre fra Romani, Sabini ed Etruschi nella valle del Tevere durante il periodo della monarchia e poi della prima età repubblicana a Roma.
Non rimangono però di Eretum resti che possano far attribuire con certezza la sua localizzazione, anche se le fonti antiche concordano nell'indicarne il sito al XVIII miglio della via Salaria, dove l'antico tracciato della consolare si incrociava con quello della via Nomentana e ipotesi recenti identificherebbero la città con i colli di Casacotta.
In località Tor Mancina sono stati scoperti resti di basolato appartenenti alla via fra Eretum e Nomentum, l’altro centro importante presente anticamente in questa regione, collegato ad un sistema viario attraverso il quale transitavano traffici e merci diretti da/per Roma e verso il sud.
Eretum gradualmente perse importanza dopo la sottomissione della Sabina a Roma, nel 290 d.C., fino a perderne le tracce: l’insediamento sembra spostato a nord-est, divenendo una stazione sulla Salaria, attorno cui gravitavano alcune ville, funzionanti anche in età tardo antica e medievale.
Al periodo medievale risalgono i primi documenti che riferiscono di un luogo su cui l’insediamento iniziale si svilupperà dando origine alla moderna Monterotondo: un “Campum Rotundum o Mons Rotundum con i suoi due casali viene donato nel 1012 all’abate di Farfa, mentre una lapide datata al 15 agosto 1152, oggi murata nella Sacrestia del Duomo, ricorda la consacrazione dell’antica chiesa di S. Maria Maddalena.
E’ la prima testimonianza della vita sociale e religiosa di una comunità che evidentemente per proteggersi si raccoglie in un luogo alto e fortificato: nuovi insediamenti, con la ripresa demografica, hanno luogo con il passaggio da habitat rurali e dispersi a quelli concentrati e difesi, i castra, secondo un processo comune a molti paesi medievali in Sabina.
A partire dal XIII secolo la storia del Castrum Muntis Rotundi , è associata con quella delle famiglie della nobiltà romana che ne ebbero la signoria, ossia prima gli Orsini, dal 1286 al 1626, e poi i Barberini.
I feudatari esercitarono l’amministrazione della giustizia, della tassazione e dei commerci delle mercanzie, soprattutto prodotti agricoli trasportati a Roma con imbarcazioni fluviali sul Tevere.
La fase urbanistica medievale del Centro Storico ancora oggi preservato si sviluppa nella parte meno elevata del colle, identificata con il Monte della Ginestra, con il tracciato delle strade ad andamento curvilineo in funzione della morfologia del suolo.
Gli Orsini fecero erigere sulla sommità della rocca la dimora signorile, dove si svolgeva la vita tipica del castello medievale, con cerimonie e feste sontuose, ricordate anche negli Archivi comunali; essi accrebbero la propria potenza soprattutto dal momento in cui un membro della famiglia, Giacinto Orsini, salì al soglio pontificio assumendo il nome di Celestino III (1191-98) e poi con il pontificato di Nicolò III, fratello di Rinaldo dal quale discendono Orso Orsini e gli Orsini di Monterotondo. Il momento più glorioso per il ramo eretino coincise però col matrimonio di Clarice Orsini con un grande protagonista del Rinascimento, Lorenzo il Magnifico (1468).
Le vicende storiche e le rivalità fra le grandi famiglie e personalità dello Stato Pontificio si intrecciano alternativamente con fasi di crescita e di benessere e fasi di guerre e di distruzioni che interessano anche il feudo di Monterotondo.
Ricordiamo tra tutti un episodio, la distruzione delle mura e di abitazioni nel 1503 per volontà d Alessandro VI Borgia, che fece avvelenare il Cardinale Battista Orsini di Monterotondo.
Durante il primo periodo della signoria dei Barberini, ai quali il possedimento fu venduto dagli Orsini per far fronte agli ingenti debiti contratti, vengono realizzate opere urbanistiche e artistiche importanti: si ristruttura sulla rocca il Castello in Palazzo (oggi denominato Palazzo Orsini-Barberini), si edifica la nuova Chiesa di Santa Maria Maddalena (il Duomo) e successivamente lungo un’ampia strada in asse alla chiesa – oggi via Cavour – si edifica secondo un progetto dai precisi rapporti spaziali la nuova urbanizzazione secentesca del Borgo.
Accanto agli edifici civili hanno nuovo impulso anche quelli religiosi: nel XVII secolo si realizzano la costruzione del Convento dei Cappuccini e si completano lavori del complesso della Chiesa e Oratorio di San Rocco.
All’inizio del XVI secolo risale la fondazione dell’antico Ospedale del Gonfalone, la cui gestione, insieme a quella dell’adiacente chiesa di San Nicola, viene affidata alla venerabile compagnia di S. Croce del Gonfalone, con il compito di assistere ammalati e pellegrini.
Nel 1699 il feudo viene venduto alla famiglia genovese dei Grillo e nel 1814 a quella dei Boncompagni.
Tutta la storia del territorio e della città di Monterotondo, dall'età preromana fino al '600, sono presentati nel Museo Archeologico e Multimediale, attraverso l’esposizione di reperti e ed esperienze visive e sensoriali di grande interesse.
Monterotondo successivamente sarà teatro di vicende risorgimentali, ed è celebre il passaggio di Giuseppe Garibaldi, nell’ambito della questione della liberazione di Roma, quando alla testa di una spedizione di volontari nel 1867 riesce ad entrare nella cittadina attraverso la Porta Romana (oggi Porta Garibaldi) e ad occupare la rocca. Non avendo però alcun appoggio della popolazione fedele al papa, le truppe garibaldini subirono la sconfitta definitiva da parte di francesi e papalini a Mentana.
Va ricordato infine che la città è uno dei tre comuni del Lazio decorato con la Medaglia d’argento al valore militare d’argento per la lotta antifascista e la resistenza agli occupanti tedeschi da parte della popolazione dopo l’8 settembre. Economia
Monterotondo è caratterizzata da attività produttive in grado di garantire discrete condizioni di vita alle comunità che l’hanno abitata. Fino agli anni '50 l’attività prevalente della popolazione era quella agricola, con la coltivazione del grano, della frutta, dei vigneti e oliveti, già fiorente in età medievale: “…In questa terra di Monterotondo non vi si ha altra mercantia, solo s’attende all’arte del campo per la bontà delli terreni, et alle vigne, de quali ci n’è gran quantità. E da quelle non solo si cava il frutto del vino, ma grandissima quantità di frutti d’estate, cioè amandole, bricocole, pere, mele, fieli di più sorta, et grandissime quantità di persiche, quali sono di molta bellezza, e bontà e se ne cava tanta frutta, che è di tanto aiuto alli uomini di detta terra; tutti questi frutti si portano a Roma…” (dall’Archivio Barberini presso la Biblioteca Apostolica Vaticana).
Con il boom economico degli anni '60 e '70 furono costruite nelle zone delle Fornaci e Valle Ricca, ma anche sulla via Salaria molte industrie, in particolare fornaci, specializzate nella fabbricazione di mattoni, ceramiche e laterizi, utilizzando come materia prima locale l’argilla delle cave coltivate nelle colline circostanti, alcune attive ancora oggi.
Le nuove opportunità di occupazione finirono per attrarre maestranze dalle regioni vicine, come le Marche, l’Abruzzo e l’Umbria, ma anche dalla Sicilia.
Fu necessario costruire per abitanti “migranti” nuovi quartieri e insediamenti abitativi, come Spinedi e Borgonovo.
Il Museo storico nella Torre Civica di Monterotondo Scalo inaugurato nel 2016 presenta documenti e installazioni multimediali sulle trasformazioni urbane e socio-culturali di Monterotondo Scalo, la memoria delle fornaci di laterizi, l’identità di quartiere, insieme alla descrizione delle vicende e della storia di Monterotondo dall'Unità d'Italia fino al 1994.
Il boom industriale si esaurisce, come nel resto d'Italia, alla fine degli anni '80 e oggi restano sul territorio le ciminiere e i fabbricati delle fornaci dismesse in attesa di progetti di trasformazione.
La città quindi si riconverte e diventa un importante centro del terziario.
L'industria, concentrata con i suoi stabilimenti - fabbriche locali ma anche filiali di grandi aziende nazionali e internazionali - nella zona industriale nella Valle del Tevere, tra la via Salaria e la Traversa del Grillo, ha ancora un ruolo chiave nell’economia della città.
Sito ufficiale del Comune di Monterotondo: clicca qui
Fonte web: Comuni-italiani.it; Tuttitalia.it; Visitalazio.com; Sabina.it; Api.culturalazio.it
Testo: Ida Anna Rapinesi
Foto: Associazione culturale ambientalista “Organizzazione Alfa”
- Tenuta di Grotta Marozza
- Area archeologica della Via Nomentum-Eretum
- Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco
- Centro Storico
- Palazzo Orsini Barberini
- Chiesa di Santa Maria Maddalena - Duomo
- Arco di San Rocco (Porta Garibaldi)
- Chiesa e oratorio di San Rocco
- Museo Archeologico e Multimediale
- Il Convento dei Frati Minori Cappuccini
- Torre Civica - Museo Storico di Monterotondo